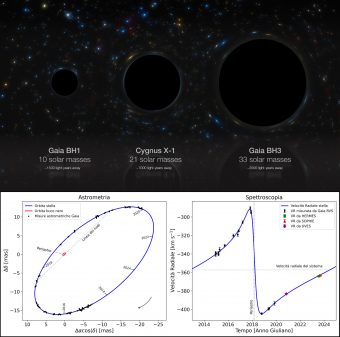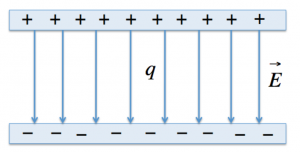Ray Charles moriva esattamente dieci anni fa, il 10 giugno 2004, a Beverly Hills, dopo una splendida vita. Lo vogliamo ricordare con un estratto dalla sua biografia, Brother Ray, pubblicata da minimum fax.
Il secondo anno a scuola fu tutta un’altra storia. Ero rilassato, perfino felice di essere lì. A quel punto mi ero fatto degli amici. Conoscevo tutti e tutti conoscevano me. Mi diedero un soprannome, Foots, “piedi”, anche se non ricordo precisamente da dove saltò fuori. Il secondo anno riuscii perfino a godermi le vacanze di Natale. Il personale della scuola fece una colletta e riuscì ad alzare grana a sufficienza per pagarmi il viaggio a casa più quello di ritorno. Pensai che dovevo stargli davvero simpatico.
La cosa più importante fu la mia educazione musicale. Per la prima volta ricevetti lezioni vere e proprie, con gli esercizietti e i pezzi classici. Mi ci applicai da subito. Una volta, però, venni quasi buttato fuori dalla scuola per una cosa che feci durante una di queste lezioni.
L’insegnante di musica, la signorina Mallard, mi chiese di eseguire il mio esercizio. Per non so per quale ragione, quel giorno non riuscivo a ricordarmi il pezzo per intero. Per cui pasticciai di brutto. Sapete, ci sono giorni in cui le dita non fanno quello che dovrebbero. Bene: la cosa fece imbestialire la signorina Mallard. Imbestialire sul serio. Feci qualche altro tentativo, ma non mi veniva. Alla fine si arrabbiò così tanto che mi schioccò il righello sulle dita.
Mi fece andare il sangue al cervello! Le saltai addosso e le diedi un pugno sul petto. Non so cosa mi aveva preso. Probabilmente stavo solo reagendo a una persona che aveva messo a repentaglio la parte più preziosa del mio corpo; sapevo che per suonare servivano le mani. Ed ero molto sensibile se qualcuno cercava di farmi qualcosa lì.
Sia come sia: l’avevo picchiata. Ed è una cosa che non si fa, soprattutto al Sud. Gli insegnanti non accettavano cazzate del genere. E lei non fece eccezioni. Lo disse al direttore. (Noi lo chiamavamo il Prof.) Lui lo disse all’amministratore capo della scuola, il dottor Settles, il quale per poco non mi rispedì da Mamma a calci in culo. Ero morto di paura. Se Mamma lo scopriva mi avrebbe ucciso. Quando la signorina Mallard capì che intenzioni aveva il dottor Settles, intervenne in mia difesa. Gli disse di tranquillizzarsi. Disse che secondo lei andavo frustato e basta e che espellermi sarebbe stata una punizione troppo severa. Buon per me. So che Mamma sarebbe stata dalla parte del direttore – non avrebbe neanche preteso spiegazioni. È così che funzionava all’epoca. I genitori non facevano domande agli insegnanti. Però vedete quant’era importante per me il pianoforte, perfino a otto anni.
Quando ero piccolo, non volevo diventare famoso o ricco, ma volevo essere un grande. Volevo essere un grande musicista e, molto presto, scoprii quali erano i grandi musicisti. Ascoltandoli. Fin dai primissimi tempi, quando ascoltavo il signor Pit giù a casa, quello che mi interessava era ottenere il rispetto dei musicisti veri. Mi ero fissato degli standard elevati. Sapevo cos’era una vera voce blues e cos’era il boogie-woogie. Sapevo cos’era il pianoforte jazz. Più crescevo più si acuiva la competizione. A livello musicale, mi formai in un’epoca dove non c’era compromesso: o il tuo strumento lo sapevi suonare, o non lo sapevi suonare. A scuola non mi era permesso suonare il boogie-woogie o il blues. Principalmente facevamo roba semplice di Chopin e piccoli valzer di Strauss. Magari per conto nostro ci ascoltavamo la musica più sporca che c’era, ma durante le lezioni non veniva tollerata.
Vi posso assicurare che nel profondo tutte e tre le mie insegnanti di scuola – la signorina Ryan, la signorina Mallard e la signora Lawrence – amavano il blues. Solo che non si pensava fosse opportuno insegnarlo. Il che mi fa pensare a una cosa che successe qualche anno dopo.
Una volta, ero già adulto, partecipai a una sontuosa cena della NAACP. Sul menù vidi che c’era una bistecca e chiesi alla responsabile perché mangiassimo cibo per bianchi. Non capivo, le dissi, perché non foglie di cavolo o zampone? Prelibatezze che secondo me tutti avrebbero preferito. “Tesoro”, mi rispose la donna, “se servissimo cibo casereccio del Sud anche qui, allora resterebbero tutti a mangiarselo a casa loro”.
Benché non ci fosse niente di casereccio nella musica che imparavo a scuola, tutta la musica mi affascinava. Ero felice ogni volta che potevo suonare dei motivi che ascoltavo per la prima volta. Imparavamo pezzi scemi come “Won’t You Come and Play with Me?”, e quando avevo undici o dodici anni entrai nel coro: ero il più giovane. Ogni volta che ne avevo l’occasione, imitavo gli ultimi successi.
A scuola avevamo una radio, e ovviamente la controllavano i ragazzi grandi: gente tipo James Kendrick, che era una vera potenza, Otis Mathews e James Young. Erano loro a decidere cosa avrebbero ascoltato tutti. E se provavi a girare una manopola, ti beccavi un ceffone sulla mano.
Ascoltavo quello che ascoltava tutta l’America: le big band. Imparai i pezzi di Glenn Miller e tutte quelle cose bellissime di Tommy Dorsey, Glen Gray e Benny Goodman. Mi piacevano tanto e mi interessava studiarne gli arrangiamenti e sentire come le diverse sezioni – ottoni, strumenti ad ance, percussioni – facevano ognuna la propria parte.
Be’, alla radio però non mandavano certo il blues fangoso del Mississippi. Quella musica la potevi trovare solamente sui cosiddetti race records, i “dischi di colore”. Ma i suoni veraci dei race records io li conoscevo già. Facevano parte di me al pari del mio naso, dei denti, dei capelli che avevo in testa. Questi altri pezzi delle big band invece erano nuovi, e mi piaceva prenderli e farli miei.
Un tizio in particolare mi faceva andare ai matti. Tutti dicevano che Goodman era un gran clarinettista, ma secondo me non era all’altezza del mio eroe: Artie Shaw. Quando ascoltai Artie Shaw in “Stardust” oppure, tempo dopo, in “Concerto for Clarinet”, persi veramente la testa. Adoravo la dolcezza del suo clarinetto, le sue linee melodiche purissime. Fu Artie Shaw a ispirarmi quando cominciai a suonare il clarinetto, più o meno a dieci anni, e gli Artie’s Gramercy Five furono uno dei primi gruppi al di là delle gigantesche big band a guadagnare il mio rispetto.
A scuola c’erano tre pianoforti: uno nell’aula esercizi delle ragazze, un altro in quella dei ragazzi, e l’ultimo, il migliore, nella cappella. (A proposito, in fondo alla cappella c’erano pure alcune file di banchi, per usarla come aula per le lezioni.) Anche a scuola c’era qualcuno che sapeva suonare come si deve.
Il migliore era Joe Lee Lawrence. Era uno dei ragazzi grandi e credete a me, il pianoforte lo sapeva suonare sul serio. Joe Lee era cieco, come pure suo fratello Ernest, che era un mio insegnante, anche lui pianista. (La signora Lawrence, mia insegnante di musica, era la moglie di Ernest.) Naturalmente Joe Lee non suonava proprio al livello di Art Tatum – e chi ci riusciva? – ma era comunque in grado di cimentarsi in quel pazzesco stile veloce e ragazzi, mi faceva veramente una grossa impressione. Chiunque sapesse suonare almeno un po’ come Art Tatum, io lo consideravo un grande. Per la mia generazione Art Tatum era il migliore in assoluto col pianoforte. Era l’eroe di tutti noi, e ancora oggi non ho mai sentito nessuno in grado di fare tutto quello che faceva lui con due mani sole.
Devo dire che perfino quando divenni piuttosto bravo al pianoforte, sapevo di non essere degno nemmeno di portargli un pitale pieno di merda, ad Art Tatum. Quell’uomo era solo in vetta e nessuno poteva avvicinarlo. Adoravo come suonava gli standard, e sapevo che era capace di suonare anche il blues veramente sporco, se voleva. Sapeva suonare qualunque cosa.
Negli anni, il mio rispetto per Art Tatum è cresciuto. Mi piacciono anche altri pianisti. Ammiro moltissimo Oscar Peterson. In effetti Oscar lo amo con tutto il cuore, ma lui sarebbe il primo a dirvi che non è al livello di Tatum. Già, Tatum era Dio. E se Dio entra dalla porta, ti alzi in piedi e gli presenti i tuoi omaggi.
Ogni volta che Joe Lee – il nostro Art Tatum – arrivava nel dormitorio, tutti i ragazzini si mettevano a urlare: “Wow! È Joe Lee! Facci sentire qualcosa di forte!” Appena metteva il piede oltre la porta bastava un attimo e già lo trovavi a strimpellare e cantare con la sua voce da contrabbasso: “Buum buum buum buum”. Sicuro, si metteva a inventare canzoni facendoci saltare tutti e ballare a oltranza come matti. Non molto tempo dopo mi trovai a fare la stessa cosa: a suonare “Honky Tonk Train” o “Beat Me Daddy” con i ragazzini tutti intorno a me. Tutto ciò, capirete, andava fatto dopo l’orario di scuola, di nascosto, nelle aule esercizi, senza insegnanti nei paraggi.
A quel punto a scuola ero parecchio socievole, anche se con chi non conoscevo ero timido. Ero uno dei pochi ragazzi ciechi in grado di comunicare con i sordi. Lo facevo perché mi andava di comunicare con loro. Imparai il linguaggio dei segni perché i ragazzi sordi potessero “parlare” con me tramite i palmi delle mie mani: mi tracciavano segni o lettere sulla pelle, con le dita. E ovviamente mi leggevano le labbra. Era divertente. Non che fossi proprio un buono. Tutt’altro. Direi che ero uno dei più irrequieti, tra i ragazzi, e avevo anche un lato cattivo. Se mi provocavano, quasi sempre rispondevo.
Mettiamo che qualcuno mi facesse uno sgarbo. Per esempio andare a fare la spia dai professori quando davo noia a una ragazzina in corridoio o quando sputavo pallottole di carta ciancicata. Una volta scoperto lo spione, e mi premuravo sempre di scoprirlo, mi vendicavo. Altroché.
Legavo un filo tra due panchine. Poi mi nascondevo e aspettavo fin quando il ragazzino in questione imboccava il marciapiede.
Ascoltarlo mentre cadeva di faccia mi dava un gran piacere. Sì, magari occorreva tempo, ma era un buon risarcimento per quel genere di debiti. E facevo sempre in modo da non rischiare di prenderle io. Lo scontro diretto non mi ha mai affascinato. Se sei in cerca di vendetta, ci sono modi migliori per riuscire a colpire qualcuno. Capitava ogni tanto che fossi costretto a fare a botte, e ricordo una volta di aver pestato la faccia a un compagno con un pezzo di carbone.
Mi mettevo anche in altri generi di casini. Se mi punivano, per dire, a tavola mettevano il mio piatto capovolto in modo che quando si serviva la cena non avrei avuto niente. Questa cosa a volte mi faceva perdere la testa, tanto che mi mettevo a scuotere il tavolo finché il cibo e i bicchieri pieni di tutti finivano per terra.
Il che ovviamente mi portava a beccarmi ulteriori punizioni. A questo punto diciamo che mi mandavano a lavare i piatti con le ragazzine per, mettiamo, tre o quattro giorni. Il che era un problema, perché tutti mi ridevano dietro come fossi la persona più idiota sulla terra. Non che mi desse fastidio stare con le ragazzine. Al contrario. Chiunque mi conosca, sa che amo le donne.
[...] Era un’epoca della mia vita in cui i miei orizzonti musicali si stavano espandendo. La musica da chiesa la conoscevo già: la cantavo da quando ero nato. Su disco ascoltai cantanti gospel come i Wings Over Jordan e il Golden Gate Quartet. A scuola cantavo nel coro, mi diedero anche una piccola uniforme, e con alcuni compagni mettemmo su un gruppetto vocale tutto nostro, informale, in cui eseguivamo lo stesso genere di musica gospel. (Ero il più piccolo del gruppo. Quando si trattava di musica, pareva che fossi sempre insieme a gente molto, molto più grande di me, sia cantanti che musicisti.)
Dovete poi tenere presente che nel Sud la musica country andava per la maggiore – la chiamavamo musica hillbilly – e non ricordo un solo sabato sera in cui non abbia ascoltato il “Grand Ole Opry” alla radio. Adoravo Grandpa Jones e tutti quegli altri personaggi. Capivo quello che facevano e apprezzavo il sentimento che ci stava dietro. Jimmy Rodgers, Roy Acuff, Hank Snow, Hank Williams e successivamente Eddie Arnold: erano cantanti che ascoltavo ogni giorno. Non ero un fanatico della loro musica, ma mi piaceva e la seguivo.
Allo stesso tempo non persi interesse nelle grandi big band dei bianchi: Dorsey, Miller, Goodman, Krupa, Shaw. E naturalmente conoscevo le big band dei neri: Jay McShann e Jimmie Lunceford, Lucky Millinder, Buddy Johnson, Basie, Ellington e dopo anche Billy Eckstine, la cui versione di “Blowing the Blues Away” è un pezzo che suono ancora. Al Hibbler che cantava con Duke, Ella con Chuck Webb o gli Ink Spots: era musica che mi colpiva al cuore. Conoscevo anche i cantanti bianchi dell’epoca: Bing Crosby, Dick Haymes, Vaughn Monroe, Tony Martin. Dei bianchi solo una mi faceva una grande impressione: Jo Stafford. La voce di quella donna aveva un tono soave che mi piaceva; c’era qualcosa di ammaliante nel suo stile.
Ascoltavo la hit parade alla radio, in quegli anni, e ascoltavo i primi dischi di Frank Sinatra, anche se credo che all’epoca fosse ancora lontano dal dare il meglio di sé, cosa che fece più avanti nella carriera; lui è uno di quelli la cui voce è migliorata e si è ammorbidita con l’età. Io il jazz lo conoscevo. Lo amavo, il jazz. Il jazz io lo sapevo suonare.
Art Tatum, come ho detto, era il Padre di tutti noi pianisti, ma avevo un grande rispetto anche per Earl “Fatha” Hines e Teddy Wilson. Non mi sfuggiva niente, ero sempre preso a imitare le nuove cose che uscivano, tanto per vedere se ce la facevo. E di solito ce la facevo. Ma fu un altro l’uomo che mi cambiò la vita col suo modo di cantare e suonare il pianoforte. Che mi influenzò più di tutti gli altri. Questo fratello fu tutto per me, non mi stancavo di ascoltarlo. In pratica lo seguii per quasi un intero decennio. A livello musicale seguii i suoi passi fino a quando non trovai un modo mio di camminare. Rubai tanti dei suoi trucchi al pianoforte. E mi ritagliai addosso alla perfezione il suo stile vocale. Era il mio idolo: sto parlando di Nat Cole. La gente si scorda che Nat Cole cominciò come pianista, e come pianista jazz. Sì, certo, suonava motivetti carini e melodie orecchiabili, ma se voleva, sapeva tirar fuori il blues più nero di tutti i tempi.
Quando più tardi, negli anni Quaranta, esplose il bop, sapeva suonare anche quello. Già, Nat Cole il pianoforte lo sapeva proprio suonare: punto e basta. E io me ne rendevo conto. Adoravo il suo modo di cantare, come scandiva le parole, la sua voce profonda, romantica, sensuale. Una ballata lui la accarezzava, ci si accoccolava dentro e la teneva accesa e calda fin dove bastava.
Nessuno sapeva accompagnarsi come Nat Cole: ecco un’altra sua caratteristica. Potreste credere che suonarsi da soli l’accompagnamento sia facile, ma sono qui a dirvi che non è così. Nossignore, quel le cosette di pianoforte con cui riempiva i vuoti improvvisando dietro la voce erano piccole gemme: sempre di gusto, sempre limpide, sempre mostruosamente originali. Ero anche consapevole di quanto Nat Cole fosse popolare negli anni Quaranta, del fatto che tutti lo amassero, e che suonando quel genere di musica stesse facendo i soldi veri.
Perciò il mio primo progetto fu questo: diventare un piccolo Nat Cole. Molti dei suoi primi pezzi, “All for You” o “Straighten Up and Fly Right”, entrarono presto a far parte del mio repertorio. Il suo stile non era il mio, il mio si sarebbe formato anni dopo, ma quello stile che aveva era una combinazione di molte delle cose che amavo: l’improvvisazione jazz, le belle melodie, i ritmi scatenati e di tanto in tanto un assaggio di blues.
Di quella scuola facevano parte altri pianisti e cantanti che mi influenzarono: per esempio Charles Brown, all’inizio della mia carriera, specialmente quando facevo la gavetta giù in Florida. Feci parecchi soldi grazie all’imitazione della sua “Drifting Blues”. Era un pezzo grandioso.
Ma credo che nessuno mi abbia influenzato come Nat Cole. Imparai velocemente che se ero in grado di rifare i suoi grandi successi potevo cominciare a ottenere io stesso degli apprezzamenti. Per cui, tra quello e il jazz che imparavo a scuola da Joe Lee Lawrence, la mia musica cominciava a prendere forma. Anche se non ero ancora nemmeno adolescente, la mia consapevolezza di musicista cominciava lentamente a formarsi.